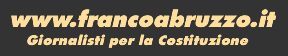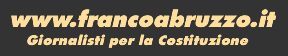di Franco Abruzzo
La legge istitutiva dell’Ordine (n. 69/1963) riconosce (all’articolo 34) tre figure di giornalisti: a) della carta stampata; b) della radio; c) della televisione. Il Contratto nazionale di lavoro giornalistico 2001-2005 aggiunge (in via sperimentale per un periodo biennale) una quarta figura, quella del redattore del giornale elettronico. La legge 150/2000 crea una quinta figura, quella del giornalista redattore degli uffici stampa (della pubblica amministrazione).
L’articolo 1 del Dpr n. 649/1976 (che ha "arricchito" l’articolo 34 del Regolamento di esecuzione della legge n. 69/1963-Dpr n. 115/1965) ha aperto le porte della professione a "coloro i quali svolgono attività di tele-cinefoto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l’informazione scritta, nell’esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione..." e ha così introdotto nell’ordinamento la figura giornalistica del tele-cine-foto-operatore. L’articolo 34 del Dpr n. 115/1965, che disciplina le modalità di iscrizione nell’elenco pubblicisti dell’Albo, va letto nel contesto della normativa sul giornalismo (i pubblicisti contrattualizzati oggi, come i professionisti, sono assicurati con l’Inpgi in base all’articolo 76 della legge n. 388/2000). L’articolo 27 della legge sull’editoria n. 67/1987 dice: "Le disposizioni della presente legge concernenti i giornalisti professionisti, nonché le altre disposizioni normative in materia, si applicano anche ai telecineoperatori di testate giornalistiche televisive, iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti". L’articolo 5 delle norme transitorie del Contratto nazionale di lavoro giornalistico (che ha forza di legge con il Dpr 153/1961), peraltro, comprende "i fotocinereporter e i telecineoperatori, che prestano attività giornalistica". "Per qualificare come giornalistica l'attività del telecineoperatore rileva non tanto il particolare modo d'uso della macchina da ripresa, quanto, e soprattutto, la capacità di trasmettere attraverso immagini, sostitutive della parola o dello scritto, un messaggio, un pensiero informativo e formativo che va al di là del mero aspetto visivo e costituisce un vero e proprio prodotto dell'intelletto" (Cass. civ., sez. lav., 14 giugno 1994, n. 5757). I Consigli dell’Ordine possono, quindi, riconoscere il praticantato giornalistico dei telecinefotoperatori, i quali, però, dopo l’abrogazione della prova di idoneità esclusiva ad essi un tempo riservata (dall’articolo 2 del Dpr n. 649/1976 cancellato dal Dpr n. 384/1993), sosterranno la identica prova di idoneità professionale prevista per i giornalisti della carta stampata, della radio, della televisione, di internet.
E’ riconosciuta altresì come attività giornalistica quella compiuta: a) dal disegnatore (Corte d’Appello di Roma, sentenza 22 novembre 1944 in Luigi Caiazza, I rapporti di lavoro dei giornalisti, pag. 39; Trib. Roma, 4 settembre 1963 in Giur.It., 1964, 463 ). Che la figura del disegnatore rientri nella concezione tradizionale del giornalismo si evince anche dalla sua espressa menzione nei più antichi contratti collettivi (14.12.1919; 1.10.1925; 5.3.1928 e 2.2.1932) nei quali, a differenza che nei successivi, esistevano più precisi riferimenti alla mansione (in Domenico D’Amati, Il lavoro del giornalista, Cedam 1989, pag. 53); b) dal vignettista (Trib. Venezia. 8 aprile 1974, Manzi c. Soc. Edit. San Marco; Cassazione civile (Sezione Lavoro), 20 ottobre 1978. sentenza n. 4761 in Pietro Zanelli, Il contratto dei giornalisti, Zanichelli 1980, pag. 28 e in Domenico D’Amati, Il lavoro dei giornalisti, Cedam 1989, pag. 53). c) dal redattore grafico. Il Dpr n. 384/1993 ha abolito l’articolo 11 del Dpr 212/1972, che, modificando l’articolo 44 del Dpr 115/1965, aveva introdotto la prova di idoneità grafica e, quindi, la figura del redattore grafico. La figura del redattore grafico oggi è citata solo nell’articolo 42 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico (). Il linguaggio grafico ha la stessa dignità di quello alfanumerico e di quello delle immagini. E’ evidente che il riconoscimento della natura giornalistica può essere positivamente rivendicato non da tutti i grafici, ma solo da quelli che possono dimostrare di lavorare sul contenuto. Conta il lavoro effettivamente svolto al fine di dimostrare la . Il giornalismo grafico era menzionato incidentalmente in poche sentenze della Cassazione tra le quali ricordiamo quella n. 6574/1981 in cui è affermato che il messaggio del giornalista può essere e quella n. 3849/1984 nella quale si rileva che il "discorso" comunicativo con il pubblico è costituito da "una composizione di elementi significativi (parole, immagini, segni in genere)" e si sottolinea il "non significativo rilievo anche informativo" della titolazione dei pezzi. Solo nel 1996 il giornalismo grafico ha ottenuto un importante riconoscimento in sede giudiziaria sintetizzato in questa massima giurisprudenziale: "Deve qualificarsi come attività giornalistica - intesa come prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione - l'attività svolta dal redattore grafico il quale, mediante l'espletamento di attività inerenti la progettazione e la realizzazione della pagina di giornale, esprime, con la collocazione del singolo pezzo giornalistico, come pure mediante la scelta dei caratteri tipografici col quale lo stesso viene riportato sulla pagina, una valutazione sulla rilevanza della notizia, valutazione rapportata ad un giudizio sulla idoneità del fatto ivi riferito ad incidere sul convincimento del lettore" (Cass. civ., sez. lav., 1 febbraio 1996, n. 889; parti in causa Minardi c. Rusconi ed; d) dall’infografico; e) dal photo-editor.
Per quanto riguarda il "giornalismo elettronico", il protocollo contrattuale "si applica ai redattori di nuova assunzione utilizzati nelle redazioni di giornali elettronici per la ricerca, elaborazione, commento, invio e verifica delle notizie ed elaborazione di ogni altro elemento di contenuto giornalistico relativo alla ricerca e predisposizione degli elementi multimediali ed interattivi da immettere direttamente nel sistema. Non sono considerate di pertinenza giornalistica prestazioni attinenti alle informazioni di servizio, pubblicitarie e di contenuto commerciale". Il contratto in sostanza ha preso atto che "la rete Internet è equiparabile a organo di stampa". "La rete Internet, quale sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche, è equiparabile ad un organo di stampa" (Trib. Napoli, 8 agosto 1997; Riviste Dir. e Giur., 1997, 472, n. Catalano).
Gli uffici stampa della Pubblica amministrazione e degli Enti Locali saranno composti da giornalisti (professionisti e pubblicisti) iscritti nell'Albo. A stabilirlo è la legge n. 150/2000 sulla comunicazione istituzionale. I capi degli uffici stampa dovranno possedere anche una laurea.
Concetto di giornalismo e di attività giornalistica.
Il giornalismo è tradizionalmente definito ; estensivamente indica anche "la professione del giornalista" e "la categoria dei giornalisti o il complesso dei giornali".
Non esiste il concetto giuridico di giornalismo. Il concetto, abitualmente estrapolato dall’articolo 2 della legge professionale n. 69/1963 (quello dedicato all’etica della categoria), si riassume nella frase . Il primo comma dell’articolo 2, infatti, dice: <È’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica.....>. Questo vuoto è stato, però, riempito da alcune sentenze della Corte di Cassazione:
a) La nozione dell'attività giornalistica, in mancanza di una esplicita definizione da parte della legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69 o della disciplina collettiva, non può che trarsi da canoni di comune esperienza, presupposti tanto dalla legge quanto dalle fonti collettive, con la conseguenza che per attività giornalistica è da intendere l'attività, contraddistinta dall'elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica (Cass. civ., 23 novembre 1983, n. 7007; Riviste: Mass. 1983).
b) E' di natura giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale (che può indifferentemente avvenire mediante l'apporto di espressioni letterali, o con l'esplicazione di espressioni grafiche, o ancora mediante la collocazione del messaggio) attraverso gli organi di informazione (Cass. 1/2/96 n. 889, pres. Mollica, est. De Rosa, in D&L 1996, 687, nota Chiusolo, Il giornalista grafico e l'iscrizione all'Albo dei giornalisti).
c) Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione; il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso...... differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione" (Cass. Civ., sez. lav., 20 febbraio 1995, n. 1827).
d) Il carattere creativo dell'attività giornalistica non significa che essa debba essere necessariamente oggetto di un rapporto di lavoro autonomo. In realtà, fermo restando il carattere essenziale della creatività, essa può costituire prestazione di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a seconda delle modalità della collaborazione tra il datore di lavoro e il giornalista. Tuttavia, il. vincolo della subordinazione assume una particolare configurazione nel rapporto di lavoro giornalistico, per la natura squisitamente intellettuale dell’attività del giornalista, per il carattere collettivo dell’opera redazionale, per la peculiarità dell'orario di lavoro e per i vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie. Ne consegue che sussiste un contratto di lavoro subordinato quando il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore per eseguirne le istruzioni, mentre sussiste un contratto di lavoro autonomo quando le prestazioni siano singolarmente convenute in base a una successione di incarichi fiduciari e la remunerazione sia subordinata alla valutazione da parte del direttore del giornale e commisurata in relazione alla singola prestazione (Cass., sez. lav., 14 aprile 1999, n. 3705).
Un aiuto per inquadrare il concetto di attività giornalistica e di giornalista viene anche da sentenze di altri e diversi giudici:
a) Deve escludersi l'ammissibilità della preposizione ad un ufficio stampa di un giornalista professionista esterno, allorché le competenze in concreto conferite alla struttura non implicano l'applicazione prevalente degli elementi della "creatività" dell' "intellettualità" e dell' "intermediazione critica" delle notizie, costituenti l'essenza della professione giornalistica dovendosi in tale ipotesi ricorrere alle prestazioni di un dipendente dell'ente, evitando ingiustificate spese aggiuntive (Corte Conti, regione Sardegna, sez. Giurisdiz., 8 giugno 1994, n. 262; Riviste: Riv. Corte Conti, 1994, fasc. 3, 118).
b) L'attività giornalistica è caratterizzata dall'elemento della creatività, per cui può essere definito giornalista con conseguente applicabilità del Ccnl relativo, colui che nel riportare una notizia compia un'opera di mediazione tra la notizia e la sua diffusione (Pret. Torino, 1 agosto 1992; Parti in causa Brunati c. Soc. ed. La Stampa; Riviste: Dir. e pratica lav., 1993, 135).
Il giornalismo, quindi, secondo la Corte di Cassazione, è caratterizzato:
a) dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione di notizie (attuali) destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale;
b) dall'elemento della creatività;
c) dalla tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione;
d) dagli elementi della "creatività", dell' "intellettualità" e dell' "intermediazione critica" delle notizie.
La dottrina e la giurisprudenza legano il giornalismo all’attualità sulla base dell’articolo 32 della legge professionale e dell’articolo 44 del Regolamento di esecuzione della stessa legge i quali prescrivono, infatti, per la prova scritta dell’esame di idoneità professionale, la . L’attualità, quindi, è una connotazione centrale e qualificante della professione giornalistica.
Il ruolo moderno dell’Ordine posto a tutela degli interessi della collettività
L’Ordine, ente pubblico, ha la specifica competenza della tenuta dell’albo, dei giudizi disciplinari, della proposta della tariffa professionale nonché della liquidazione dell’onorario. Tali funzioni sono assegnate a tutela non degli interessi della categoria professionale ma della collettività nei confronti dei professionisti: questo principio è fissato nella sentenza n. 254/1999 del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (magistratura equiparata al Consiglio di Stato). Molti sostengono, invece, che "gli Ordini hanno la finalità di tutelare (solo) gli interessi della categoria". Ma non è così. Secondo il Consiglio della Giustizia amministrativa della regione siciliana, gli Ordini devono tutelare gli interessi dei clienti dei professionisti. "Le specifiche competenze della tenuta dell’albo, dei giudizi disciplinari, della redazione e della proposta della tariffa professionale nonché della liquidazione dei compensi — scrive il Cgars – sono assegnate dalla legge agli Ordini essenzialmente per la tutela della collettività nei confronti degli esercenti la professione, la quale solo giustifica l’obbligo dell’appartenenza all’Ordine, e non già per una tutela degli interessi della categoria professionale che farebbe degli Ordini un’abnorme figura d’associazione obbligatoria, munita di potestà pubblica, per la difesa di interessi privati settoriali". Un concetto, questo, che prefigura un ruolo moderno degli Ordini non più intesi come corporazione ma come enti che concorrono ad attuare valori e finalità propri della Costituzione repubblicana.