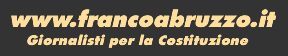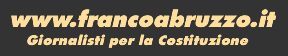Il presidente Mattarella ha visto Manzoni in un’ottica che supera la dimensione letteraria. Nell’immenso romanzo, nella vicenda di quello scrittore, ha letto in filigrana le storie nostre qui e oggi; Renzo e Lucia sono diventati i protagonisti di una saga che ha come teatro noi, e l’Italia. Il presidente ha fatto di “don Lisander” l’interprete di fatti che superano quel XVII secolo in cui si svolge la vicenda, superano anche l’ottica ottocentesca nella quale Manzoni è vissuto e ha scritto per guardare alle incertezze e alle miserie del presente. Ha detto il presidente: «È la persona, in quanto figlia di Dio, e non la stirpe, l’appartenenza a un gruppo etnico o a una comunità nazionale, a essere destinataria di diritti universali, di tutela e di protezione. È l’uomo in quanto tale, non solo in quanto appartenente a una nazione». Parole che spengono i tentativi non sappiamo se più goffi o maligni di resuscitare categorie come l’etnia, la stirpe, la razza, condannate per sempre dalla storia — e dall’antropologia. Manzoni era cattolico ma uno di quei cattolici che capivano i tempi, evitavano di agitare gli inutili fantasmi di un passato che non reggeva più l’urto della modernità. Quando il 20 settembre 1870 i bersaglieri posero fine al dominio temporale dei papi, lo scrittore si rallegrò non perché apprezzasse la violenza di qualche cannonata contro le mura di Roma, gioì perché vedeva la fine ad un equivoco divenuto intollerabile, perché capiva che l’azione spirituale della Chiesa aveva tutto da guadagnare dalla perdita dei fardelli e degli intrighi della politica. Così ragionano gli spiriti presaghi, le intelligenze consapevoli. Lo scrittore sapeva di che cosa è fatta la sopraffazione e la connivenza, di questo scrive. Mette in pagina l’Italia degli umili e dei giusti, gli contrappone l’Italia degli arroganti e dei predatori. Qual è infatti l’Italia dei Promessi sposi ? Che posto occupiamo noi in quell’atroce storia? In quel romanzo disperato, come lo definì giustamente Leonardo Sciascia? Siamo, per esempio, testimoni di quanto accade nel quinto capitolo quando Fra’ Cristoforo sale al palazzo di don Rodrigo per distoglierlo dal progetto criminale di portare a letto per capriccio la promessa sposa di un poveretto. Il frate viene ammesso nella sala da pranzo, vi trova don Rodrigo, circondato dai suoi amici e complici. Alla destra siede il cugino conte Attilio, a sinistra il podestà ovvero «quel medesimo a cui, in teoria, sarebbe toccato a far giustizia a Renzo Tramaglino, e a far stare a dovere don Rodrigo». Di fronte al podestà, siede ossequioso, pronto a ridere ad ogni parola del padrone di casa, l’avvocato Azzecca-garbugli eccetera. Ha detto il presidente Mattarella a Milano: «Figlio del proprio secolo, Manzoni ha avuto la peculiarità — che appartiene solo ai grandi — di gettare sulla società e sulla realtà storica del suo tempo uno sguardo lungimirante, capace di andare oltre ». Qui è la prova. Dove l’abbiamo vista la scena descritta nel quinto capitolo? Dove l’abbiamo letta? L’abbiamo vista al cinema, letta nei romanzi sulla mafia e sulla camorra; l’uomo di potere siede a tavola, ride e beve con i custodi della legge, gli stessi che dovrebbero difendere gli umili dalla sua arroganza. È andato così oltre, Manzoni da arrivare fino a noi. Quale differenza con il misero sguardo, le paure, di chi non osa progettare per il bene di tutti perché teme di compromettere il bene proprio. Mattarella: «Bisogna riflettere sulla tendenza, registrabile in tutto il mondo, delle classi dirigenti a assecondare la propria base elettorale o di consenso e i suoi mutevoli umori, registrati di giorno in giorno attraverso i sondaggi». Quando parlava dei Promessi Sposi, il grande critico Ezio Raimondi non si stancava di ripetere che un’appendice indispensabile alla vicenda di Renzo e Lucia, quasi un ultimo capitolo, è la storia della colonna infame. Se nel romanzo, pur nella tragedia, si apre qualche spiraglio di luce, nella Colonna ogni luce è scomparsa « La Colonna infame resta per sempre il luogo della percezione della tragedia che a un certo punto diventa silenzio [...] battaglia tra la verità e l’errore, l’innocenza e la colpevolezza, la giustizia e il potere». È stata bella la lettura che il presidente Mattarella ha dato del nostro massimo capolavoro ottocentesco. Anche lui, come Manzoni, appartiene a quella cultura cattolica di ampia liberale visione che molto ha contribuito all’incivilimento del nostro paese. La sua lettura “politica” è stata non solo giusta ma necessaria — forse addirittura utile — in un momento di enorme confusione dove troppi rappresentanti delle istituzioni appaiono pericolosamente disorientati. Tra le parole del romanzo citate nell’intervento c’è anche una frase che suona come un monito di fronte a tante tremebonde cautele: «Il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune». Vengono anche da qui, le tragedie.
àààààààààààààààààààà
La Repubblica Martedì 23 Maggio 2023 Pagina 2 - Il retroscena -
LA PREOCCUPAZIONE DEL COLLE DIETRO IL RICHIAMO FORTE AI VALORI FONDANTI DELLA CARTA. Il riferimento non casuale allo scrittore “cattolico integrale ma non integralista”.
Di CONCETTO VECCHIO
Una critica al nazionalismo esasperato, al populismo come facile scorciatoia, contro i vaneggiamenti sull’etnia. Sbagliato contrapporre Dio, patria e famiglia contro i valori liberali di libertà, eguaglianza e fraternità. Cattolici integrali non integralisti, nazionali non nazionalisti, popolari non populisti. Parlando di Alessandro Manzoni, ieri a Milano, Sergio Mattarella parla all’Italia, in un discorso denso e alto che è un richiamo ai valori della Repubblica, ai suoi fondamentali. Il governo non viene nominato, naturalmente, ma ci sono rimandi che fatalmente richiamano il dibattito politico di queste settimane, o almeno questo è il senso che se ne ricava. Ci sono almeno quattro argomenti che rappresentano una risposta indiretta alle ideologie della destra al governo. Sul populismo intanto. Sull’unità d’Italia, proprio mentre si discute dell’autonomia indifferenziata. Sull’integralismo e sull’etnia, è l’uomo, la persona al di là delle razze, delle etnie e nazionalità a godere dei diritti universali, a necessitare della sua protezione: tutto questo arriva poche settimane dopo l’uscita del ministro Lollobrigida, mai citato. La Costituzione, ricorda, sbarra «espressamente la strada a nefaste concezioni di supremazia basate su razza e appartenenza ». Citando Manzoni ricorda che «è la persona, in quanto figlia di Dio, e non la stirpe, l’appartenenza a un gruppo etnico o a una comunità nazionale, a essere destinataria di diritti universali, di tutela e di protezione. È l’uomo, in quanto tale, non solo in quanto cittadino, a essere portatore di dignità e di diritti». Non è un attacco al governo, né ai suoi ministri, fanno notare dal Quirinale, ma è indubbio che, dopo quello sulla Resistenza il 25 aprile, è un altro capitolo della pedagogia civile avviata da tempo dal Presidente, che parla sul piano politico-culturale. E che in qualche modo incrocia i temi buttati sul tavolo dalla destra oggi al potere. Viene fuori un’altra idea di Paese, da cattolico democratico, da difensore strenuo dei valori della Costituzione. Ed è una critica feroce a chi cerca facili consensi piuttosto che impostare politiche di ampio respiro. «Dedicarsi a costruire politiche di ampio respiro, capaci di resistere agli anni e di definire il futuro». C’è un legame con i ritardi sul Pnrr («mettersi alla stanga», aveva ammonito un mese fa), mentre divampa la battaglia culturale? Di certo al Quirinale guardano con estrema preoccupazione ai ritardi sul Piano di aiuti europei. L’Italia è in grave ritardo, in un tema che la Presidenza della Repubblica sempre ha ritenuto cruciale per ammodernare e rilanciare il Paese, un’occasione unica che non tornerà. Mattarella attualizza quindi Manzoni, il suo lato politico, di cattolico adulto, di milanese che «ambiva a un’Italia unita, che non fosse una mera espressione geografica, una addizione a freddo di diversi Stati e staterelli». E un contributo alla riflessione mentre il Parlamento si divide sull’Autonomia differenziata voluta dalla Lega. E infine un invito ad amministrare la cosa pubblica con saggezza, non adulando le folle. Si corrono rischi enormi nel vellicare gli umori delle folle anonime, «un combinato micidiale che invece di generare giustizia, ordine, prosperità - che è il compito precipuo di chi è chiamato a dirigere - produce lutti, tragedie e rovine». È un discorso di storia patria, ma parla all’Italia di oggi. Specie a quella al potere.