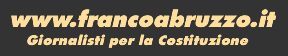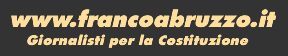Roma, 7 ottobre 2022 - “Rispetto, trasparenza e fiducia: si tratta di tre componenti dell’indipendenza della magistratura, che devono essere valutate e misurate rispetto ad altri poteri. La riflessione su standard comuni che garantiscano un funzionamento indipendente della magistratura dovrebbe essere portata più apertamente in primo piano, in uno sforzo congiunto necessario a rafforzare lo stato di diritto in tutto il mondo”.
È il passaggio finale della relazione inviata alla Conferenza Mondiale sulla Giustizia Costituzionale (WCCJ), in corso a Bali dal 4 al 7 ottobre e dedicata a GIUSTIZIA COSTITUZIONALE E PACE, dalla presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra, impossibilitata a partecipare di persona alla sessione “Rendiconto sull’indipendenza dei tribunali membri”, presieduta dal presidente della Corte costituzionale austriaca Christoph Grabenwarter.
Sciarra, oltre a ricordare il ruolo chiave dell’indipendenza dei media nel promuovere l’indipendenza della magistratura, ha proposto di far circolare il più ampiamente possibile i risultati degli incontri della Conferenza, per esempio attraverso dichiarazioni congiunte da consegnare alla stampa e, se concordato, pubblicate nei siti web dei tribunali membri del WCCJ.
La Conferenza Mondiale sulla Giustizia Costituzionale riunisce 119 Corti e Consigli Costituzionali e Corti Supreme in Africa, Americhe, Asia, Australia/Oceania ed Europa. Promuove la giustizia costituzionale – intesa come revisione costituzionale inclusa la giurisprudenza sui diritti umani – come elemento chiave per la democrazia, la tutela dei diritti umani e lo stato di diritto.
Lo scopo principale della Conferenza mondiale è facilitare il dialogo giudiziario tra i giudici costituzionali su scala mondiale.
Poiché questi giudici a volte si trovano in situazioni di conflitto con altri poteri statali a causa delle loro decisioni, la partecipazione alla Conferenza mondiale offre un forum che non solo consente di scambiare liberamente informazioni, ma anche di offrire sostegno alle Corti. Questo può essere importante per difendere i principi costituzionali, che i giudici sono chiamati a proteggere.
Qui il link alla relazione della Presidente Sciarra
Qui il link al programma del WCCJ
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
IDENTITA’ NAZIONALI E PRIMATO DEL DIRITTO EUROPEO, STATO DI DIRITTO E INDIPENDENZA DEI GIUDICI NAZIONALI: in linea da oggi, in modalità multimediale, tutti i materiali dell’incontro tra la Corte costituzionale e una delegazione della Corte Ue. TESTO IN https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20221007114849.pdf
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
In gioco Valori e interessi - TRA DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE.
di GIULIANO PISAPIA/Corriere della Sera 7.10.2022*
Caro direttore, esistono molti modi di mettere in discussione l'Europa specie dopo il fallito assalto «no euro» degli anni passati. Gli stessi che criticavano la moneta unica sono ora in fila per chiedere più soldi a Bruxelles e alla Bce. Si sta infatti profilando una nuova strategia, più subdola: quella di proporre modifiche nell'ordinamento costituzionale italiano che però finirebbero per minare l'esistenza stessa dell'Unione.
Il punto principale, citato esplicitamente in Italia da importanti esponenti della nuova maggioranza, è quello di eliminare, completamente o solo parzialmente, il principio di gerarchia che vede il diritto comunitario prevalere in molti casi su quello nazionale. Il risultato concreto sarebbe il ritorno a una sostanziale anarchia giuridica in cui ogni Stato della Ue potrebbe fare come vuole, con l'addio a ogni politica comune europea. Salterebbe de facto il principio stesso di unione.
A favore della revisione del principio di primazia tra diritto comunitario e nazionale vengono spesso richiamate le decisioni della Corte costituzionale tedesca. È stato sostenuto che la Corte avrebbe affermato che fra i due sistemi normativi, prevale sempre quello che più tutela i cittadini tedeschi. Non ultima viene annoverata la celebre sentenza del 5 maggio 2020 della Corte di Karlsruhe relativa all'applicazione del quantitative easing da parte della Bundesbank nel rispetto dei provvedimenti della Banca centrale europea.
Una decisione che però ha trovato l'immediata risposta della Commissione, del Parlamento e della Corte di giustizia europea che hanno ribadito il primato delle decisioni comunitarie sui temi espressamente previsti dai trattati Ue. È stata anche aperta una procedura d'infrazione contro la Germania per violazione degli obblighi derivanti dai Trattati.
Se la questione con la Corte costituzionale tedesca sembra - al momento - rientrata, diverso è il discorso con la Consulta polacca. Con sentenza del 7 ottobre 2021 - a seguito di un giudizio promosso dal primo ministro polacco - la Corte ha indicato che l'interpretazione secondo cui le disposizioni del Trattato sull'Unione europea porterebbero al primato delle norme di diritto internazionale sarebbero incompatibili con la gerarchia delle fonti di diritto vigente in Polonia.
Il Parlamento europeo, a distanza di due settimane esatte da quella esplosiva sentenza, ha adottato una risoluzione in cui «deplora profondamente la decisione del 7 ottobre 2021 del Tribunale Costituzionale» e la definisce illegittima «in quanto compromette il primato del diritto dell'Ue come uno dei suoi principi fondamentali ed esprime profonda preoccupazione per il fatto che tale decisione potrebbe costituire un pericoloso precedente».
Spesso si dimentica che il Trattato di Lisbona - che definisce i limiti delle competenze degli Stati membri e dell'Unione europea - è stato approvato nel 2008 all'unanimità dal nostro Parlamento, sia alla Camera che al Senato. Gli ambiti in cui i singoli Paesi, compresa l'Italia, hanno deciso di concedere all'Unione europea e il primato del diritto europeo su quello nazionale sono quindi stati concordati, sottoscritti e ratificati da tutti i Paesi europei, incluso il nostro che storicamente ha sempre svolto un ruolo fondamentale nella costruzione del progetto europeo, a partire dal Trattato di Roma del 1957.
Troppo spesso si dimentica anche che è la nostra Carta costituzionale a consentire la limitazione della sovranità nazionale per contribuire alla creazione di un ordine internazionale che «assicuri la pace e la giustizia tra Nazioni» e che «le leggi debbono rispettare i vincoli comunitari» (articoli 11 e 117). La prevalenza della normativa Ue, del resto, riguarda solo le poche competenze esplicitamente attribuite dai trattati (unione doganale, regole su mercato interno, politica monetaria per i Paese con l'euro, risorse del mare e per la pesca e politica commerciale comune).
Le numerose restanti materie sono rimaste di competenza nazionale o condivisa. Ad esempio neppure la sanità è di competenza Ue, anche se poi, il contributo positivo dell'Europa è stato fondamentale per contrastare il virus.
Ecco perché, soprattutto in questo periodo difficile e complesso, le proposte che hanno l'effettivo obiettivo di minare il principio di supremazia della legge comunitaria su quella dei singoli Stati non inducono certo serenità nei nostri partner europei e stanno già facendo emergere dubbi, preoccupazione e mancanza di fiducia nei confronti del nostro Paese, con tutte le conseguenze economiche e sociali che ne conseguono. Era da augurarsi che simili proposte fossero solo boutade propagandistiche, ma al contrario trovano nuova vita anche dopo la campagna elettorale. Se il nostro Paese è cresciuto in termini di prosperità e ha oggi gli strumenti e le potenzialità per superare l'attuale momento difficile e delicato, lo deve anche, e in alcuni casi soprattutto, all'integrazione europea che si è sviluppata, quando necessario, anche con la supremazia della legge comunitaria su quella nazionale. Interrompere l'integrazione europea, ponendo fine a principi fondamentali, esporrebbe il nostro Paese (più di altri) a conseguenze incalcolabili e impensabili. L'Italia, paese fondatore prima della Comunità e poi dell'Unione europea, non può permettersi di diventare attore della messa in discussione delle sue basi fondative. Sono in gioco i nostri valori ma, è bene ricordarlo, anche i nostri interessi.
*vicepresidente Commissione Affari costituzionali Ue