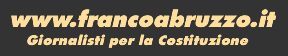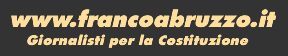|
 |
|
|
La “cassoeula” mangiare lombardo. Nel nuovo libro culinario di Emilio Magni.
21.11.2018 .-In italiano dovrebbe chiamarsi “bottaggio”. Però quasi nessuno adopera questa parola. Quel bel “mangiare” lombardo, così gustoso e grasso, fatto con le frattaglie, ovvero gli scarti della macellazione del maiale abbinati alle verze, è per tutti, per il popolo e per i dotti, la “cassoeula”. Un termine del dialetto milanese che è un gentile ritocco di “cazoeula”, o “cazzoeula”, addirittura “cazoeura” termini della parlata brianzola e della fascia prealpina. Quale è quello giusto? Vanno tutti bene. Con il dialetto non c’è un codice. Quando ci si sente chiedere come si dice una parola in dialetto, bisognerebbe rispondere: «Si dice come lo diceva mia nonna». Il dialetto varia da contrada a contrada, anche se la radice è quella meneghina, ovvero il dialetto di Carlo Porta. Lo stesso discorso vale per la “cassoeula”. Ogni paese ha la sua ricetta che i paesani dicono che è quella della vera “cassoeula”. Di questo “mangiare”, così saporito, ricco di fantasia e di storia contadina, un secolo fa quasi una trasgressione per la povera schiatta della gleba, è da qualche anno assurto al livello di una grande star nel gaudente ed epicureo mondo dei buongustai lombardi , in particolare brianzoli e lariani: anche meneghini: tanto per prenderla alla larga e abbondare. Vanno sempre più matti per la “cassoeula” il popolo di tutte le età, la “noblès”, la gente semplice e pure i raffinati, gli “scì scì”, come direbbe Gianni Brera, che ha celebrato la “cassoeula” nel suo libro “La Pacciada”. Un tempo deliziosa pietanza per poveri contadini, la “cassoeula” è ora sui menù di “millanta” trattorie e ristoranti che fanno a gara a cucinarla. A Cantù da qualche anno organizzano addirittura il “Festival de la cazoeula”. Vi partecipano oltre quaranta tra ristoranti e trattorie. A cogliere questa eccitazione per un piatto che, a guardar bene, viene dalla povertà, è stato Emilio Magni, giornalista brianzolo, una vita da cronista, a La Provincia di Como, poi a Il Giorno, il quale ha dedicato a questo “mangiare” addirittura un libro dal titolo “Il sorriso della cassouela” edito da Mursia. Magni ha dedicato alla cultura e alle tradizioni del mondo contadino brianzolo e lombardo in generale una serie di libri, questo della “cassoeula” è il nono, tutti pubblicati da Mursia. Per la “nobile schiatta della zolla” la “cassuoela” è stato, secondo Magni, il riscatto del povero mondo contadino nei confronti dei signori potenti di Milano. Questo accadde nel 1600 durante la dominazione spagnola. Le ricche famiglie della città, quasi sempre legate a doppio filo, pronte e assai ruffiane davanti al governatore iberico (che ricambiava con qualche bel privilegio) arrivano nel contado ad acquistare, pagando un prezzo da fame, le parti migliori del maiale che i contadini allevavano proprio per cercare di rendere meno atroce la loro fame. Prese le parti nobili del “purcèll” i signori meneghini lasciavano lì le frattaglie, gli scarti della macellazione. Erano una mezza delizia per il povero desco della famiglia contadina. Un giorno però una “resgiura” deve aver intuito, chissà grazie a quale ispirazione , che abbinando le verze rimaste a gelare nell’orto alle cotenne, le costine, le altre frattaglie scartate dai milanesi, veniva fuori un “mangiare” assai gustoso. Era nata la “cassoeula”: una delizia completa. Magni racconta che fu una servotta arrivata dalla Brianza alla corte di un signorotto milanese ad insegnare la “cassuola” alle raffinate cuoche della famiglia, abituate a cucinare ben altri manicaretti. Non furono quindi gli spagnoli, come molti hanno scritto a portare a Milano questo piatto, bensì fu il contrario. - Emilio, Magni,“Il sorriso della cassoelula” (Ed. Mursia). 16 €
|
 |

|