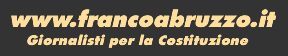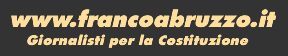di Aldo Natalini
Le molestie perpetrate a mezzo mail, quand’anche siano idonee a ledere la tranquillità del destinatario, non sono sussumibili sotto il reato di molestie private, ostandovi il divieto di analogia in malam partem. Così la Cassazione, con l’interessante sentenza 24510/2010 che nega la possibilità di interpretare estensivamente la previsione di cui all’articolo 660 Cp, escludendo senza mezzi termini che l’espressione incriminante la molestia od il disturbo recati «col mezzo del telefono» possa essere dilatata sino a comprendere l’invio di corrispondenza elettronica sgradita al destinatario e che ne provochi turbamento o, quanto meno, fastidio. Dunque, sulla pur avvertita esigenza di espandere la tutela del bene protetto (della tranquillità privata), la Suprema corte antepone - ineccepibilmente - il limite coessenziale della legge penale, costituito dal principio di tassatività e di tipizzazione delle condotte illecite, sanciti dall’articolo 25, comma 2, della Costituzione e dall’articolo 1 del Cp. Come a dire che, sull’interpretazione evolutivo-tecnologica della fattispecie, prevale il valore legalistico-costituzionale, che è pur sempre espressione di libertà.
La stretta interpretazione dell’espressione: «col mezzo del telefono». Alla base del dictum in commento v’è un’attenta esegesi dell’espressione «col mezzo del telefono», come noto tipizzata ex articolo 660 Cp quale modalità commissiva alternativa a quella del «luogo pubblico od aperto al pubblico».
Nella fisionomia della fattispecie de qua, il turbamento di chi è stato oggetto di una molestia rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per integrare la fattispecie, dovendo concorrere (alternativamente) gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, tipizzati dalla norma incriminatrice: la pubblicità (o l’apertura al pubblico) del teatro dell’azione ovvero l’utilizzazione del telefono come mezzo del reato. Ed in particolare il telefono assume rilevanza, per l’ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico, «proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita (articolo 15, comma 1, Costituzione)».
La necessaria interazione tra mittente-destinatario. Orbene - spiega la Cassazione - mentre nel caso dei messaggini di testo (sms) non v’è dubbio alcuno sull’integrabilità della contravvenzione in esame, essendo il destinatario di essi costretto, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario (così Cassazione, Sezione terza, 26 giugno 2004, n. 28680), viceversa l’invio, anche ripetuto, di messaggi di posta elettronica - esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale - «non comporta (a differenza della telefonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo».
Sicché non coglie nel segno per la Suprema corte l’opposta esegesi sposata - nella specie - dal giudice di merito, secondo cui anche la «e-mail viene propriamente inoltrata col mezzo del telefono»: in realtà tale rilievo è improprio ed inesatto perché la posta elettronica “utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, né costituisce applicazione della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci e suoni”. In sostanza - argomentano esaustivamente gli “ermellini” di Piazza Cavour - tutte le volte in cui le modalità di comunicazione sono asincrone, disgiungendosi l’emissione dell’improperio e la sua ricezione, si fuoriesce dall’ombrello punitivo dell’articolo 660 Cp, sotto il quale sono sussumibili, invece, solo le azioni perturbatrici sincrone: quali, per l’appunto, quelle telefoniche e quelle citofoniche, che alle prime sono in tutto e per tutto assimilabili perché coinvolgenti pur sempre espressioni vocali profferite contestualmente in danno del ricevente (in tal senso Cassazione, Sezione sesta, 5 maggio 1978, n. 8759, Ciconi, Rv. 139560).
Di contro, nel caso di comunicazioni effettuate con lo strumento della posta elettronica, l’azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (con la possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione della memoria dell’elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all’elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di pota elettronica e proceda alla lettura del messaggio.
In questo contesto di comunicazione non simultaneo, assimilabile alla tradizionale corrispondenza epistolare in forma cartacea, inviata, recapitata e depositata nella cassetta (o casella) di posta sistemata presso l’abitazione del destinatario - l’invio di un messaggio di posta elettronica - esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale - non comporta (a differenza della telefonata) alcuna interazione immediata tra mittente e destinatario. E tanto basta alla Suprema corte per stroncare l’applicazione dell’articolo 660 Cp: un bell’esempio di resistenza nomofilattica alle velleità analogico-punitive che, in materia penale, sono sempre dietro l’angolo, soprattutto quando in gioco c’è - come nella specie - una contravvenzione evidentemente non più in linea con i tempi e con le tecnologie telematiche di cui, ormai, non possiamo più fare a meno.
tratto da "Diritto&Giustizia"
in http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/responsabilita-sicurezza/news/articolo/lstp/303632/ (20 agosto 2010)